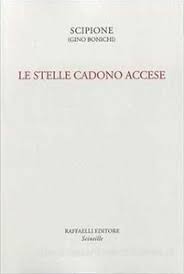Aleksandr Blok, Paul Celan, I dodici (a cura di Dario Borso), L'arcolaio 2018
Interessante
ed intelligente operazione editoriale, quella di riunire in un unico volume, a
cura di Dario Borso, la traduzione dal russo de I dodici di Aleksandr Blok e la traduzione dal tedesco del medesimo
testo nella versione di Paul Celan. Il poema, infatti, scritto da Blok nel
gennaio 1918, venne poi tradotto quarant’anni dopo da Paul Celan, che si occupò
anche di Esenin e di Osip Mandel’štam, accumunando così “tre poeti, la cui
esistenza fu annientata dagli sviluppi involutivi della Rivoluzione d’Ottobre”,
come afferma Borso nell’introduzione al libro.
I dodici
è un poema che ci trasporta, con una
scrittura scossa e sincopata, in perenne movimento, nello spirito
rivoluzionario del tempo, in quell’oltre
non solo politico, ma anche esistenziale verso cui il nuovo corso storico sembrava
tendere, in un processo di fine, ma anche di principio, di impulso utopico e di rinascita, all’insegna di un
cambiamento radicale, che non poteva non coinvolgere anche la parola poetica.
Così,
con I dodici Blok abbandona il
simbolismo, lascia le forme espressive già collaudate, e approda a una
scrittura spezzata, ritmica, in marcia,
mentre tutto è in divenire.
L’intenzione era quella di rappresentare il nuovo che avanzava, la tenacia inarrestabile
di un sogno in grado di travolgere il passato e di proiettarsi verso il futuro,
alternando immagini emblematiche al dinamismo della parola. Blok dichiarerà,
successivamente, nell’aprile 1920, spento ormai l'entusiasmo iniziale: “La
verità è che il poema fu scritto in uno di quei periodi straordinari e sempre
brevi, in cui il ciclone rivoluzionario in corso provoca una tempesta in tutti
i mari – nella natura, nella vita e nell’arte”.
E
la scrittura di Blok è qui simile a una musica che si scompone e si ricompone
nei passi e nelle voci dei dodici rivoluzionari che marciano, dentro il buio
della sera, nonostante imperversi una
terribile bufera di neve. L’oscurità, il vento e il ghiaccio non impediscono
il loro procedere eroico, che è inframmezzato dall’apparizione di vari personaggi
legati alla tradizione e destinati perciò a essere travolti dal processo
rivoluzionario in corso: tra gli altri, una vecchietta, un letterato, un prete,
un borghese, còlti in pochi tratti, ma con ferocia e sarcasmo, nei loro atteggiamenti
di paura e di rifiuto.
Tutto
avviene nel vento, nel turbinio della neve, al passo della rivoluzione, tra i
fuochi accesi intorno, coi berretti sgualciti, le cicche tra i denti, i fucili
e le bandoliere. Sembra che qualcosa di superiore debba veramente affermarsi,
al di là delle singole esistenze, qualcosa di epocale, che va ben oltre le
vicende private di ognuno. E non è certo di poco conto l’episodio di Piotr, che
uccide per gelosia la sua amata prostituta Katia, ma che poi i compagni riescono
a ricondurre all’impegno rivoluzionario.
C’è
movimento nel movimento, in questo
poema, qualcosa che procede trasformandosi, e che di volta in volta è marcia
trionfale, sberleffo, balletto, dramma, fino al colpo di scena finale, quando
davanti al corteo dei dodici, “indifferente alla bufera, incede lieve, /
perlaceo di neve attorno a sé” Gesù Cristo.
È
questa un’immagine inaspettata, che compare improvvisamente e che lascia per un
momento interdetti, ma che forse può essere compresa non tanto in un’accezione
religiosa, quanto in una prospettiva di umanità
nuova, di nuovo Regno sulla
terra, di cui Cristo può essere considerato il simbolo-guida. A tal proposito,
si può fare riferimento, solo a mo’ di esempio e per intenderci, al pensiero
del tedesco Ernst Bloch, alla sua speranza
di emancipazione, diversa dalla fede alienata,
ma necessaria per coltivare uno spirito di utopia
in vista di un Regno messianico di giustizia e di pace: questa aspettativa,
probabilmente, non fu del tutto estranea anche al poeta russo, almeno al
momento delle prime fasi della rivoluzione.
Dopo, infatti, Blok rimase profondamente deluso dagli esiti del processo
rivoluzionario, si trovò politicamente sempre più isolato e avvilito e lo stesso poema non
ebbe vita facile. E questo è un altro argomento di interesse nei confronti
dell’opera di Blok, che inevitabilmente ci interroga sul rapporto quanto mai controverso e conflittuale tra
ideologia ed esistenza, tra utopia e storia. Altro elemento degno di attenzione
è costituito poi dalla traduzione di Celan, che rende il testo ancora
più dinamico, incalzante e franto rispetto all’originale, mediante "una nominalizzazione spinta", come sottolinea Dario Borso nella già citata introduzione.
Non
pochi sono dunque i motivi di riflessione e di discussione che offre questa particolare, elegante e accurata edizione de I dodici, che raccomandiamo al lettore.
Mauro Germani